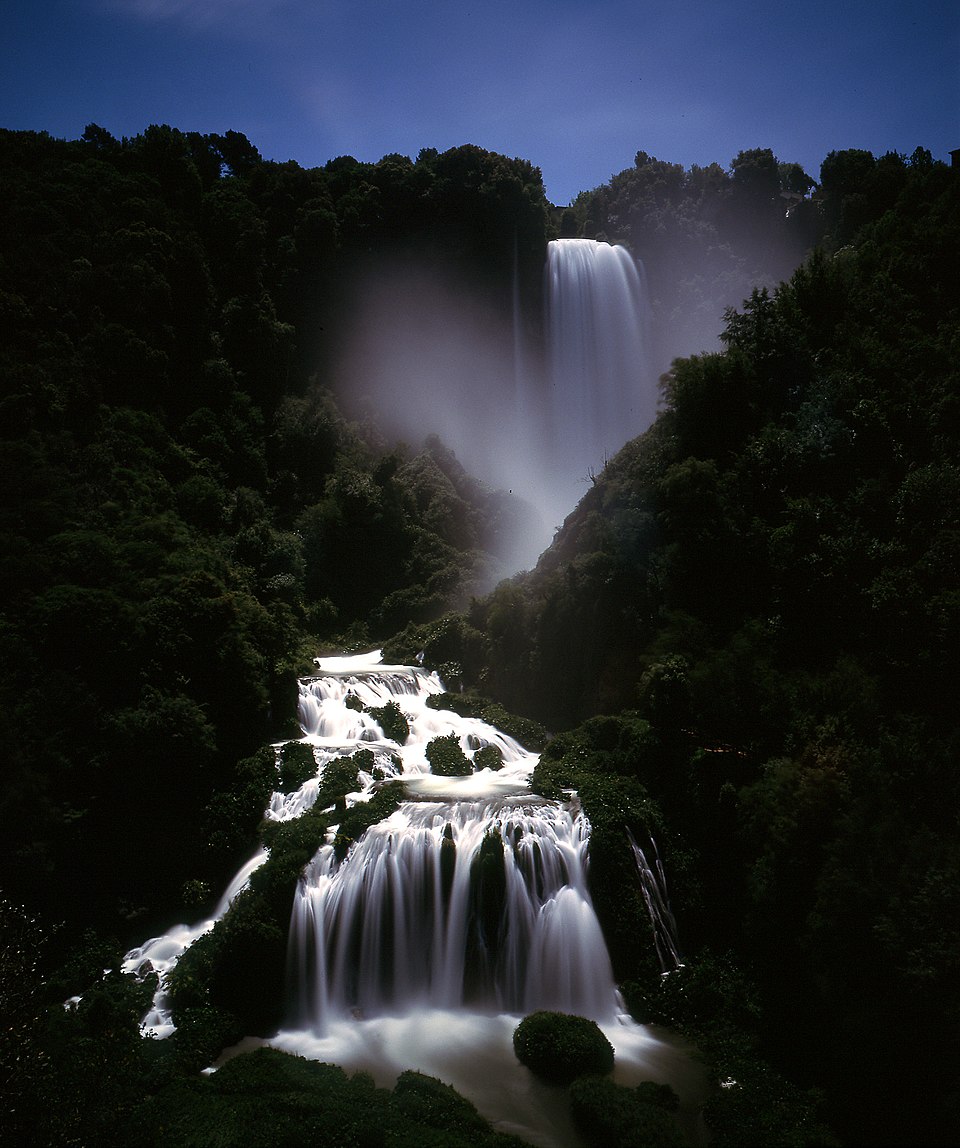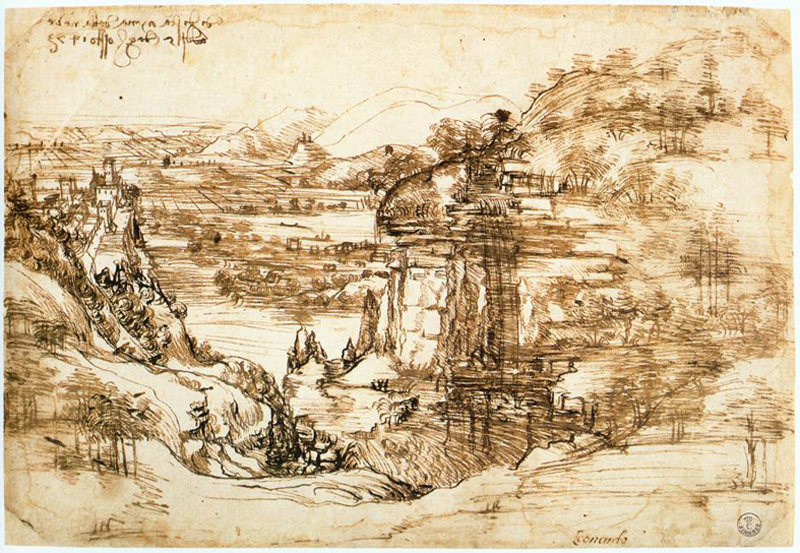TERRITORIODai suoi punti più distanti, ovvero il
Passo delle Capannelle a nord-ovest e le gole di
Popoli a sud-est, il massiccio misura circa 50 km in lunghezza e 15 km in larghezza con un perimetro di circa 130 km; orientato da nord-ovest e a ovest a sud-est, come la grande maggioranza dei
gruppi montuosi appenninici e preappenninici, ma con caratteristiche ben più aspre di
alta montagna, fa parte della dorsale più orientale dell'Appennino abruzzese assieme alla
Maiella più a sud e consta di due sottocatene principali parallele in senso longitudinale: la prima, più orientale e più aspra, si estende dal
Monte Corvo (2.623 m; nord-ovest) al
Vado di Sole (1540 m; sud-est).
La sottocatena occidentale, meno elevata e aspra, si estende invece dal Passo delle Capannelle e dal
Monte San Franco (2.132 m; nord-ovest) al
Monte Capo di Serre (1.771 m; sud-est); al di là di questa zona centrale vi è un'ampia zona sud-orientale, chiamata dei "
contrafforti occidentali"; questi sono caratterizzati da numerosi rilievi meno elevati:
Monte Ruzza (1.643 m),
Monte Bolza (1.904 m),
Monte Camarda (1.384 m),
Monte Cappucciata (1.802 m),
Monte Picca (1.405 m) e molti altri, fino alle gole di
Popoli. Le cime maggiori si trovano nella sottocatena settentrionale: il
Corno Grande (che consta di quattro vette principali, quella Orientale (2.903 m), la Centrale (2.893 m) il Torrione cambi (2.875 m) e la maggiore, quella Occidentale (2.912 m, che è anche la vetta più alta di tutti gli
Appennini) e il
Corno Piccolo (2.655 m); incastonato dentro una
conca e protetto dalle quattro vette che costituiscono il
Corno Grande si trova il
Ghiacciaio del Calderone, il secondo
ghiacciaio più meridionale d'Europa.
GEOMORFOLOGIAAlternativamente il massiccio può essere suddiviso in tre grandi aree latitudinali: la parte settentrionale dal Passo delle Capannelle al
Monte Portella che raggruppa le cime maggiori, la parte centrale corrispondente all'altopiano di Campo Imperatore con le sue cime e la parte meridionale che degrada dolcemente da
Campo Imperatore fino alla
Valle del Tirino e all'
Altopiano di Navelli con i suoi borghi montani; nel cuore del massiccio, tra le due sottocatene, è presente il vasto altopiano di Campo Imperatore e tra le cime maggiori la conca di
Campo Pericoli, oltre che profonde valli che ridiscendono tra le suddette cime (
Vallone delle Cornacchie,
Valle dell'Inferno,
Val Maone,
Valle del Rio Arno,
Valle del Venacquaro,
Valle del Paradiso,
Val Chiarino); da un punto di vista geomorfologico, il massiccio presenta scenari paesaggistici abbastanza diversi e unici nei due versanti: quello occidentale aquilano scosceso, ma prevalentemente erboso, e quello orientale teramano a maggior dislivello più aspro e roccioso.
Complessivamente l'altitudine, la composizione delle rocce, il tipo di
erosione a cui è stato soggetto, fanno del Gran Sasso la
montagna appenninica più simile ai
gruppi alpini dolomitici; data la sua elevazione, che la differenzia dalle altre catene appenniniche, il massiccio è ben visibile da tutti i principali gruppi montuosi dell'Appennino centrale e oltre, dal
Monte Conero al
Gargano e anche, nelle giornate particolarmente limpide, dai massicci montuosi della
Dalmazia (
Alpi Dinariche).
IDROGRAFIA Le
Cascate del Vitello d'Oro, situate nel territorio del comune di
Farindola, sono considerate le cascate più spettacolari del massiccio del Gran Sasso d'Italia, con un salto di circa 28 m. Altre importanti cascate sono la
cascata di Bisenti con un salto di circa 70 m e le
Cascate del Ruzzo entrambe nel territorio del comune di
Isola del Gran Sasso.
Il massiccio ospita il
Ghiacciaio del Calderone, posto sul versante settentrionale del
Corno Grande, tradizionalmente considerato il ghiacciaio più meridionale d'
Europa; in tutta l'area sono inoltre presenti anche alcuni
glacio nevati e
nevai: i più importanti si trovano alle pendici del
Corno Piccolo, sotto uno sperone roccioso a metà strada tra il
Rifugio Franchetti e la Sella dei Due Corni, noto come
glacionevato Franchetti; sul
Monte Infornace in un canalone fino alle vicinanze della vetta, innevato solitamente tutto l'anno, è presente invece il
Nevaio di Fonte Rionne; nei pressi del
Monte Camicia sono presenti due
nevai perenni uno dei quali a circa 1150 m noto come
Nevaio del Fondo della Salsa. Numerose, d'inverno, sono le
cascate di ghiaccio, alcune delle quali si trovano alla base del Monte Camicia, sempre nella zona del
Fondo della Salsa, mentre altre cascate importanti sono
Ghiaccio del Sud e la
Cascata del peccato.
FLORA E FAUNAIn particolare, l'essenza maggiormente penalizzata fu proprio l'
abete bianco, caratteristico di queste zone in quanto furono aree rifugio della specie durante le glaciazioni; oggi questa meravigliosa
conifera vegeta soltanto nei pressi dell'Eremo di Santa Colomba, Selva degli Abeti, Incodaro, Campiglione, Nerito.
Per parlare della flora del Gran Sasso, bisogna distinguere, anche in quest'ambito, fra i due versanti, quello teramano e quello aquilano. Il primo, esposto a nord-est, è caratterizzato da un substrato argilloso ed è soggetto a maggiori precipitazioni; questi fattori favoriscono l'egemonia del
faggio, con lo sviluppo di faggete di notevole pregio. Il versante meridionale, al contrario, possiede un substrato calcareo ed un clima continentale. Questi fattori favoriscono principalmente lo sviluppo di boschetti di
pioppi, di
carpini e di
cerri. Sono presenti, nell'areale, il nocciolo, il castagno (su suoli subacidi e acidi), l'
acero (spesso presente con esemplari mastodontici), tigli, Olmo montano e il Frassino maggiore. Sui versanti più soleggiati si può trovare il
sorbo montano e il ciliegio selvatico.
Sporadica è la presenza della
betulla bianca relitto di epoca glaciale. Solo grazie a rimboschimenti sono presenti il
pino nero, Pino silvestre, l’Abete di Douglas, l'
abete rosso, e il
larice. L'introduzione di quest'ultima specie si è rilevata utile poiché ben si adatta alle condizioni ambientali severe del luogo tanto da svolgere funzione pioniera per l’espansione del bosco ad alta quota. A Fonte Vetica e Valico di Capo la Serra, l’abete rosso è stato reintrodotto a partire dal 1901 dopo la sua scomparsa in epoca romana a insieme al larice e all’abete bianco. Anche questa specie si è rinaturalizzata favorendo l’espansione del bosco in ambienti difficili per il Faggio.
Tra gli arbusti possono essere menzionati il
ginepro, il
mirtillo (commestibile), la
belladonna (di aspetto simile al mirtillo, ma velenoso e, talvolta, addirittura mortale), l'
agrifoglio. Le fioriture sono caratterizzate da
gigli (specie protetta da una Legge Regionale dell'Abruzzo),
campanule, sassifraghe,
primule,
genziane, garofanini e numerose orchidee. Menzione a parte merita la
stella alpina appenninica, una pianta rarissima sulle montagne dell'
Appennino.
L'esponente più imponente della fauna del Gran Sasso è l'
orso marsicano, una sottospecie endemica dell'Appennino, di taglia relativamente ridotta, che fino a qualche anno fa sembrava scomparsa ma che recentemente è stata monitorata nelle sporadiche incursioni nei territori del parco nazionale.
Presenti anche esemplari di
lupo appenninico e di
volpe.
Altri comuni mammiferi che vivono nel territorio sono: il
gatto selvatico, il
cinghiale, il
cervo ed il
capriolo. Il
camoscio appenninico si era estinto sul Gran Sasso (per l'eccessiva caccia) intorno al 1890, ma è stato reintrodotto nel 1992, ed ora forma una colonia stabile composta da oltre 1.000 esemplari
[10].
Fra i
rapaci meritano menzione l'
aquila reale, il
falco, il
grifone la
poiana comune e lo
sparviero. Spicca, fra gli altri uccelli, la presenza del
gracchio alpino e del
picchio. Fra i rettili va segnalata la
vipera dell'Orsini, anch'essa endemica, di dimensioni inferiori rispetto alla
vipera comune e caratterizzata da velenosità meno letale e pressoché innocua, vista la rarità degli avvistamenti di tale specie. Staziona nelle pietraie, vicino ai corsi d'acqua e nelle zone di bassi cespugli di ginepro evitando, ove possibile, il contatto con l'uomo.